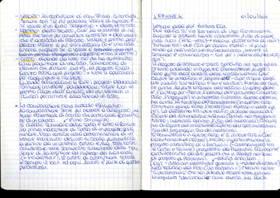Il valore della Permanenza
Published by virgilio ciancio on 19 Maggio, 2012 - 19:12Il valore della Permanenza
Nell’ultima lezione abbiamo affrontato vari temi, uno in particolare ha attirato la mia attenzione ed è quello della permanenza, permanenza intesa come valore.
Ma cosa è permanenza?
Una permanenza è ciò che persiste nel tempo, rimane e viene ereditato.
Diventiamo quindi eredi inconsapevoli di tracce di passato che entrano nella nostra memoria collettiva.
Riconoscere queste tracce di passato non è semplice e immediato, in quanto “assorbite” nella maglia regolare dell’edificato. E’ necessario analizzare lo sviluppo urbano, che è differente da luogo a luogo, specifico di un’area e riferito a un determinato periodo storico, unito alle conoscenze tecniche e materiali.
Quindi metodi di costruire differenti a seconda dei luoghi che si collegano e sono intrisi delle tradizioni ereditate dal passato. Tali azioni permangono nei manufatti e sono di assoluta importanza poiché costituiscono i riferimenti ed i modelli seguiti in passato, che servono come fonte di conoscenza e continuano a fare da modello ancora oggi.
Secondo Saverio Muratori la struttura attuale della città è la storia: la struttura attuale è, infatti il frutto di una successione di concetti di città, varianti nel tempo, e riconoscibili perché comuni ai singoli individui che vi hanno operato.
Quindi la città, con il suo continuo divenire, cresce su se stessa, arricchisce la sua memoria e in essa permangono i motivi originali.
Saverio Muratori sperimenta la sua analisi urbana su Venezia individuando in tal modo il tessuto base e gli elementi ricorrenti.
Gianfranco Caniggia successivamente, tra il 1959 e il 1963, utilizza il metodo di studio introdotto da Muratori applicandolo alla città di Como, scelta anche per la facilità di lettura dell’impianto.
Da questa analisi rintraccia la “matrice genetica” di Como che, rimasta sostanzialmente inalterata per due millenni, appare come il risultato della collocazione del castrum romano nella convalle.
Inoltre è stato possibile al Caniggia l’individuazione di più impianti, con la successiva determinazione di elementi tipici ricorrenti.
E’ necessario, pertanto, cogliere il rapporto primigenio che corre tra sito ed insediamento, attraverso la lettura della sua attuale forma, della struttura fisica e sociale che lo costituisce, e delle funzioni che ad esso sono attribuite.
Nella città di Roma è possibile riconoscere molti segni che, l’evoluzione continua e costante dell’opera dell’uomo ha lasciato.
Ne sono esempio: il Palazzo Massimo alle Colonne che, cristallizza il ricordo di un tracciato che non c’è più, la Colonna Traiana che segna il livello del terreno pre-sbancamento della collina della Velia oppure Palazzo Montecitorio che si caratterizza per la sua facciata convessa, dovuta all’andamento del terreno e delle vie circostanti ormai perdute.
Concludo quindi riportando alcune parole del libro di Aldo Rossi “L’architettura della città”, che sottolineano come queste “eredità” entrino a far parte del nostro patrimonio e come l’Architetto in quanto “artista vocato alla trasformazione dello spazio civile” deve sempre tenere in buona considerazione.
“Progettare l’Architettura significa portare a coerenza le spinte della contemporaneità e quelle della memoria: e la città è il deposito della memoria.”







 Andamento completamente diverso nei cantieri di casal palocco e infernetto, dove previa una progettazione più dettagliata e in qualche modo ‘tecnica’ il progetto ha subito poche modifiche, legate soprattuto a problemi strutturali nati in seguito a perizie specifiche.
Andamento completamente diverso nei cantieri di casal palocco e infernetto, dove previa una progettazione più dettagliata e in qualche modo ‘tecnica’ il progetto ha subito poche modifiche, legate soprattuto a problemi strutturali nati in seguito a perizie specifiche.