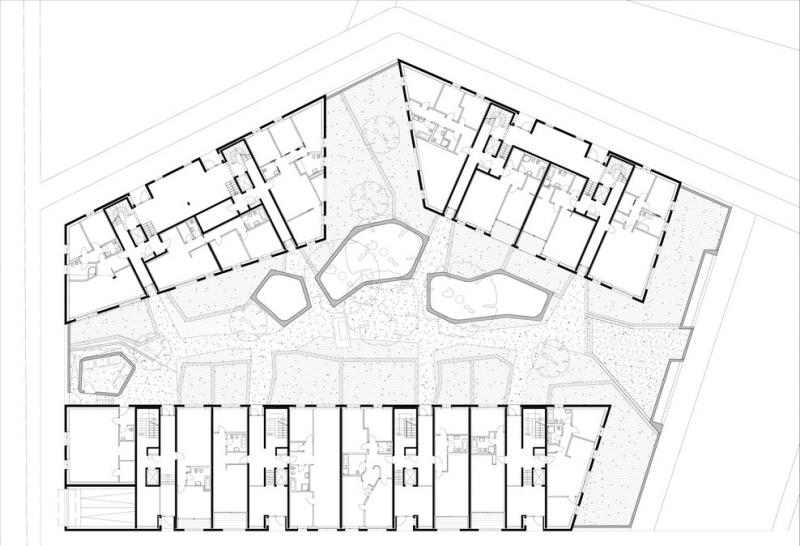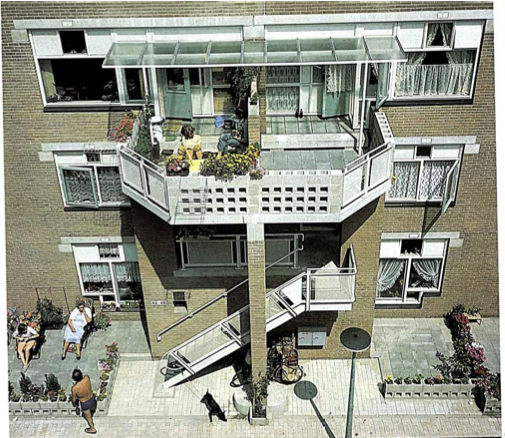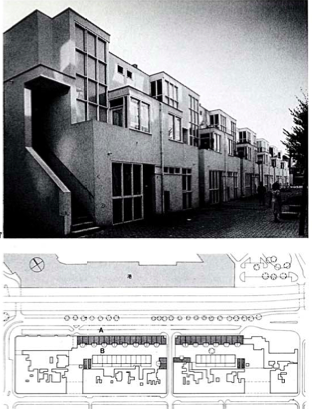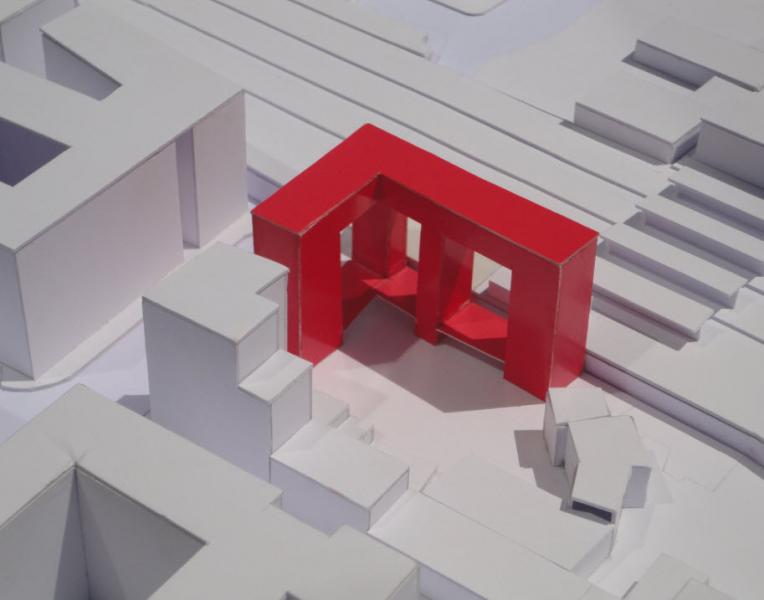Riflessione sulle diverse metodologie di intervento
Published by Martina Esposito on 4 Maggio, 2012 - 15:37Abbiamo visto durante i nostri studi e durante la scorsa lezione del prof. Passeri, come si sia intervenuto nel sito archeologico di Cnosso (il più importante sito archeologico dell’età del bronzo di Creta). Gli interventi condotti dall’archeologo Sir Arthur Evans agli inizi del 1900 furono interventi di tipo non conservativo e non scientifico, ma piuttosto di tipo “romantico”: ricostruire l’immagine del palazzo, secondo una visione del tutto personale e con materiali estranei alla tradizione minoica, per rendere il sito leggibile ai visitatori.
Materiale principe di questi interventi fu il cemento armato. Se pur oggi ciò ci appare un intervento del tutto errato, inconcepibile ed incondivisibile, non ci possiamo stupire in fondo della scelta fatta da Evans in quanto fino a pochi anni fa il cemento veniva considerato il nuovo materiale da costruzione per eccellenza. Sulla scia di queste considerazioni possiamo inoltre citare le innumerevoli Carte del Restauro, o simili, che a partire proprio dal Novecento furono redatte per dare un codice di comportamento a coloro i quali dovevano operare sul contesto storico da restaurare. Una delle prime carte in cui erano trascritte le “regole del comportamento” fu la Carta di Atene (1931), all’interno della quale ritroviamo questa disposizione: “approvato l’impiego giudizioso di tutte le risorse della tecnica moderna, e più specialmente del cemento armato”. Proseguendo all’interno della Carta italiana del restauro (1932) si incoraggia l’uso delle nuove tecnologie come quella basata sull’uso del cemento armato. Con tali premesse non possiamo stupirci del fatto che Evans abbia scelto questo materiale per i suoi interventi, come non possiamo stupirci del fatto che il “nuovo” campanile in piazza San Marco, ricostruito dopo il crollo (1912), abbia una struttura interamente in cemento armato, o di come Balanos nei suoi interventi al Partenone abbia reintegrato pesantemente colonne e trabeazioni con il cemento armato (1920), o ancora di come Muñoz abbia utilizzato questo nuovo materiale per il restauro di un monumento molto vicino alla nostra facoltà come è il Portico degli Dei Consenti al Foro Romano.
D’ altra parte è da relativamente poco tempo che i restauratori, gli architetti, gli archeologi, nonostante le differenze di pensiero sulle modalità di operare sul campo (restauro filologico – restauro critico), siano più attenti alle operazioni da eseguire in un caso di restauro di un bene archeologico o monumentale. Di questo si ebbero i primi sentori già nel 1972 quando, all’interno della Carta del restauro, si iniziò a parlare di “reversibilità” nell’intervento di restauro, così da salvaguardare e rendere possibile qualsiasi intervento successivo. Nella Carta della Conservazione e del restauro degli oggetti d’arte e cultura (1987) redatta con la coordinazione di P. Marconi, si evidenzia come l’esperienza abbia reso noto quanto invasivi, poco duraturi e irreversibili siano gli interventi con materiali moderni quali cemento armato , acciaio, resine.
Prova di questo cambio di pensiero sono tutti gli interventi successivi a questa “moda” che vedono l’uso di materiali congrui con l’edificio storico e con la tradizione cui esso appartiene. Per riprendere un caso in precedenza citato per interventi incongrui ed invasivi, quale il Partenone, negli ultimi interventi di restauro notiamo un forte cambio di rotta, dovuto all’adesione delle nuove idee di rispetto e conservazione della forma e del materiale dell’oggetto storico da parte degli operatori. Nonostante le polemiche e i dibattiti, sostenuti anche in aula, rispetto a questi interventi, mi vedo favorevole rispetto questo modo di operare; ritengo che il ripristino del monumento con l’uso del materiale originale distinto solo nelle forme (mancanza di scanalature nelle colonne o di decorazioni nelle trabeazioni ecc.) sia il risultato più giusto in questo contesto tra tutte le possibili soluzioni adottabili. Guardando al passato inoltre, seppur non come risultato di una scelta critica, questo tipo di intervento era stato già realizzato proprio nel Foro Romano, sull'Arco di Tito. Mi sento di sottolineare che attualmente, almeno per quanto mi riguarda, andando a visitare questo monumento non mi sento affatto disturbata dall'intervento di restauro condotto da Valadier, ma anzi mi rendo conto che senza quell'intervento io oggi non potrei fruire di tale opera. Penso quindi che ciò può considerarsi valido anche per il sito archeologico dell'Acropoli di Atene; unica nota che penso si possa obiettare per il momento sta nel fatto dell'attuale impatto visivo degli elementi di anastilosi; certo è che così come è accaduto al Foro anche ad Atene il loro impatto andrà via via a diminuire fino a scomparire.
Diversa è la sorte di molte altre opere di restauro che purtroppo lasceranno per sempre il loro segno sull'oggetto di intervento. Uno tra questi è la Casa delle Armi di Moretti presentataci nella lezione dello scorso venerdì. Come detto dal prof. Passeri questa architettura realizzata tra le due guerre è stata totalmente negata con i successivi interventi di trasformazione che ne hanno cancellato ogni tratto originario. Con questo esempio, oltre a ribadire l'uso errato dei nuovi materiali nelle operazioni di trasformazione negli edifici storici, si ripercorre il problema centrale della scorsa consegna, ossia l'importanza delle scelte effettuate dalle Soprintendenze per quanto riguarda le trasformazioni da attuare in questi edifici. Ritengo che non si posso parlare di restauro di un edificio storico nel momento in cui questo venga privato delle sue caratteristiche spaziali e formali principali, piuttosto si tratta di una profonda ristrutturazione che dell'edificio storico lascia solo l'involucro, l'immagine esterna. Purtroppo oggi nulla possiamo fare per rimediare a questo tipo di interventi.
Demolire? Non so rispondere a questa domanda; nonostante tutto anche se profondamente trasformate qualcosa di queste architetture è ancora lì, visibile.
Ripristinare? Anche se queste architetture fossero riportate al loro stato originario certo è che non sarebbero le architetture originali e si potrebbe parlare di un falso storico.
E chi investirebbe per tali opere? Quanto sarebbe disposto a pagare? Difficile dirlo. Sicuramente tutti siamo d'accordo sul fatto di proteggere, conservare e rendere fruibili i monumenti del nostro patrimonio ma, seppur essi siano beni inestimabili e tale dovrebbe essere il valore della loro conservazione, a che prezzo? Credo che nessuno abbia una risposta univoca ma che questa cambi a seconda del caso che ci si trovi davanti.